Chronicon farfense
Dopo trenta anni buoni, su invito di Alberto Morresi, sono tornato
a leggere questo libro di Gregorio di Catino, vissuto all'incirca fra il 1066 e
il 1133. Non certo le pergamene originali, ma nell'edizione del 1903 a cura di
Ugo Balzani, che a quanto sembra è l'unica in circolazione. Credo che studiosi
capaci di leggere le pergamene originali siano una razza in estinzione.
Peccato, perché le pergamene possono fornire particolari interessanti, come
cancellature, inserzioni, delezioni, strappi in punti strategici, eccetera.
Di documenti originali del periodo carolingio, al di fuori degli
MGH, avevo trovato solo questo nella biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata.
Sfogliando questo libro ammuffito ricordo chiaramente che mi sorprese trovare
in poche pagine tre o quattro diplomi con la dicitura " actum in aquis
palatio ", sarebbe a dire ad Aquisgrana.
Fu uno dei motivi che mi spinsero a dar ragione a Giovanni
Carnevale: come facevano dal Nord della Germania, a quei tempi, ad occuparsi
degli "scatafossi" sparsi per l'Italia centrale?
Perché poi, se questi documenti sono stati redatti a corte dell'Imperatore
non sono stati inseriti negli MGH? E' possibile che Pertz e compagnia
bella non conoscessero il "Chronicon farfense"?
La risposta che oggi mi sorge spontanea è che questi documenti
avrebbero dato ai teutonici parecchie gatte da pelare.
Prendiamo ad esempio il diploma riportato a pag. 191 "actum Aquis palatio... IIII
kalendas martii... anno imperii Domni Karoli... unctionis suae
primo" alla presenza del notaio Inquirino e del
vicecancellario Liutgardo, "et
de anulo nostro supter eam iussimus sigillari", fornito
cioè non solo della firma ma anche dell'impronta dell'anello del grande Capo.
Sembrerebbe chiaro che in data 26 febbraio 801 l'abate Ingoaldo
ottiene da Carlo Magno la conferma dei benefici rilasciati al monastero di
Farfa dai re Longobardi.
Ma c'è un problema.
Nel Natale dell'800 Carlo Magno fu incoronato a Roma, che sta in
Italia. Il 29 marzo 801, partito da Roma, si trovava a Spoleto, attesta
Eginardo, dove fu testimone di un disastroso terremoto. Anche Spoleto sta in
Italia. Dato che il documento ha tutti i crismi per essere veritiero, il
Grande Carlo avrebbe a Roma preso il titolo di "Imperatore", attraversò
le Alpi in pieno inverno per mettere il suo sigillo sul diploma in questione ad
Aachen in meno di due mesi, sempre in inverno avrebbe di nuovo attraversato le
Alpi per stare a Roma neanche un mese dopo, per essere poi puntuale a prendere
la strizza del terremoto di Spoleto.
Carlone fu buttato giù dal letto all'ora seconda della notte, più
o meno verso le 22, forse interrotto sul più bello di una prestazione amorosa
di cui era ancora capace, dopo aver pasteggiato a formaggio pecorino,
specialità del posto.
Il Mabillon, racconta Balzani, trovò la cosa inverosimile, per cui
scrisse che il Carlo del documento doveva essere il nipote, quello detto
"il Grasso" e che l'anno era l'881. Ma per dire questo si è dovuto
inventare un abate Ingoaldo II che non risulta da nessuna parte, che Gregorio
di Catino, di solito così preciso, avrebbe dimenticato di inserire nell'elenco
degli abati.
Anche il Muratori, come Mabillon, attribuì il diploma a Carlo III
il Grosso ma avendo scoperto che a quella data il personaggio stava in Italia,
cercò una "Aquis" a Sud delle Alpi.
In un primo momento gli andò bene Aquiterme nel Monferrato, ma poi
scoprì che proprio in quel giorno Carlo III risultava essere a Siena, per cui
l'enigma gli rimase insoluto.
Insomma per insigni storici come Mabillon, Muratori e Balzani il
documento è rimasto un rompicapo senza soluzione, perché per loro Aquisgrana
non poteva essere che Aachen.
Con la teoria di Giovanni Carnevale tutte le elucubrazioni di
insigni storici si sciolgono come neve al sole.
La soluzione è Aquisgrana nella Francia Picena
Enzo Mancini 29
settembre 2024



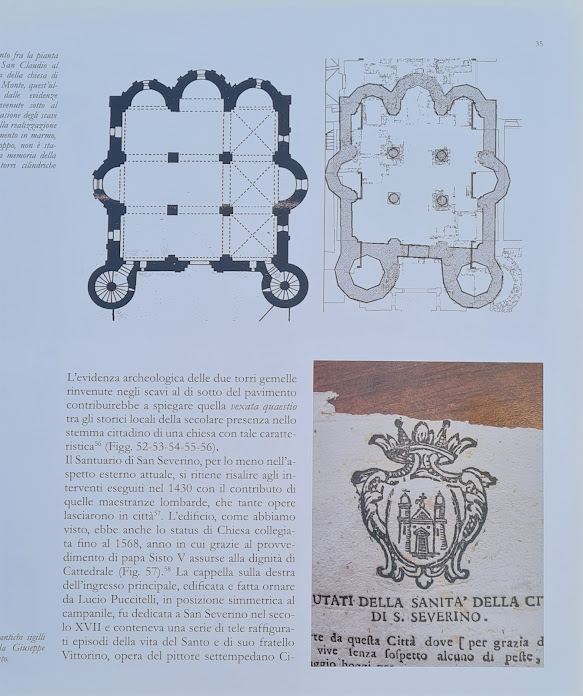
.JPG)
